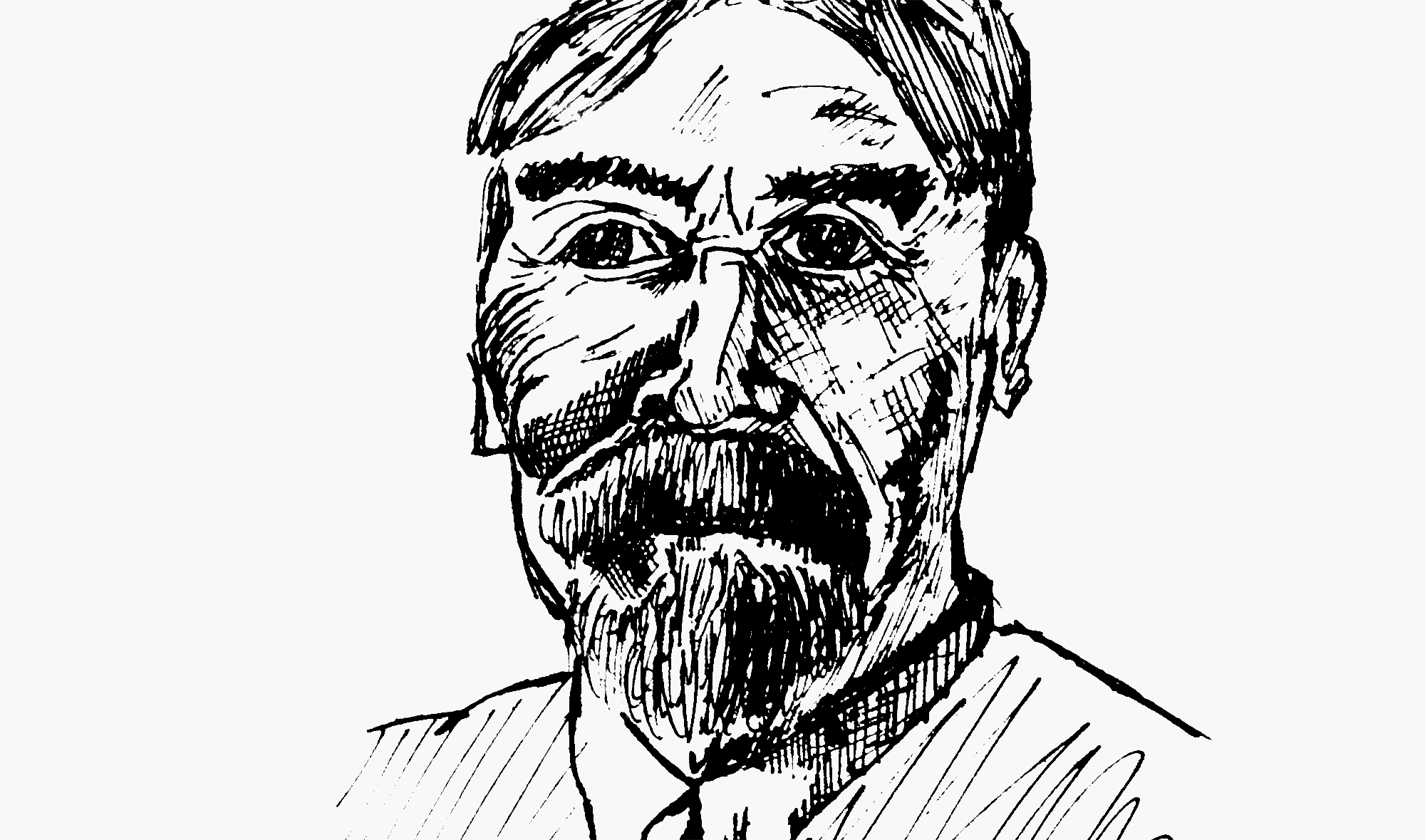A un certo punto della sua lunga storia infatti, l’uomo si è svegliato in un mondo dove la finanza e l’economia hanno cominciato a contare più di ogni altra cosa. Un mondo dove i paesi sono il PIL che fanno, gli uomini i soldi che hanno e le banche i crediti che danno. Ma questa non è una novità. Più di un secolo fa, l’economista Thorstein Veblen aveva capito che dopo i cacciatori, dopo i guerrieri e dopo i feudatari, nella società industriale la gerarchia si fonda sulla potenza finanziaria e la finanza è entrata nella vita di tutti noi.
 Negli ultimi cinquant’anni l’utilizzo della parola «povertà» è più che raddoppiato. È sulla bocca di tutti. E tutti si sentono sempre più poveri. Ma poveri di cosa? Di soldi ovviamente. Nella cultura capitalista il povero è chi non ha o chi ha poco. Come i proletari di Marx, che non avevano nulla all’infuori dei propri figli. Ma povero nella sua accezione etimologica non è colui che non ha ma colui che non fa. Il che è molto differente. La parola «povero» viene dal latino pauca (poche cose) pariens (da părĭo – produrre) da cui pauper colui che produce poco e non colui che guadagna poco.
Negli ultimi cinquant’anni l’utilizzo della parola «povertà» è più che raddoppiato. È sulla bocca di tutti. E tutti si sentono sempre più poveri. Ma poveri di cosa? Di soldi ovviamente. Nella cultura capitalista il povero è chi non ha o chi ha poco. Come i proletari di Marx, che non avevano nulla all’infuori dei propri figli. Ma povero nella sua accezione etimologica non è colui che non ha ma colui che non fa. Il che è molto differente. La parola «povero» viene dal latino pauca (poche cose) pariens (da părĭo – produrre) da cui pauper colui che produce poco e non colui che guadagna poco.
E questo è un grosso errore perché vuol dire confondere l’azione con le sue conseguenze. Il non avere è una conseguenza del non produrre. E non viceversa. L’atto di essere povero (nel suo significato reale) è l’azione che porta alla conseguenza di essere povero (nel suo significato odierno). Anzi, il non avere spesso porta al fare, porta a quell’ingegno popolare e creativo che sta alla base dell’innovazione. E, in quanto tale, è uno stimolo. In questa direzione quindi i poveri non sono coloro che non hanno ma coloro che non fanno. Quelli che si rassegnano. Quelli che non hanno il coraggio di portare avanti le proprie idee. Quelli che hanno rinunciato all’inventiva e all’entusiasmo. Quelli che non investono. E quelli che dicono no ancor prima di aver capito a cosa stanno rinunciando.
Questa è la povertà che ci dovrebbe spaventare di più, perché questa è la povertà che porta poi a quella povertà economica di cui tanto si parla oggi e, soprattutto, che alimenta quell’esercito industriale di riserva, fatto di disoccupati e inattivi, che affligge il nostro (come quello di molti altri) Paese.